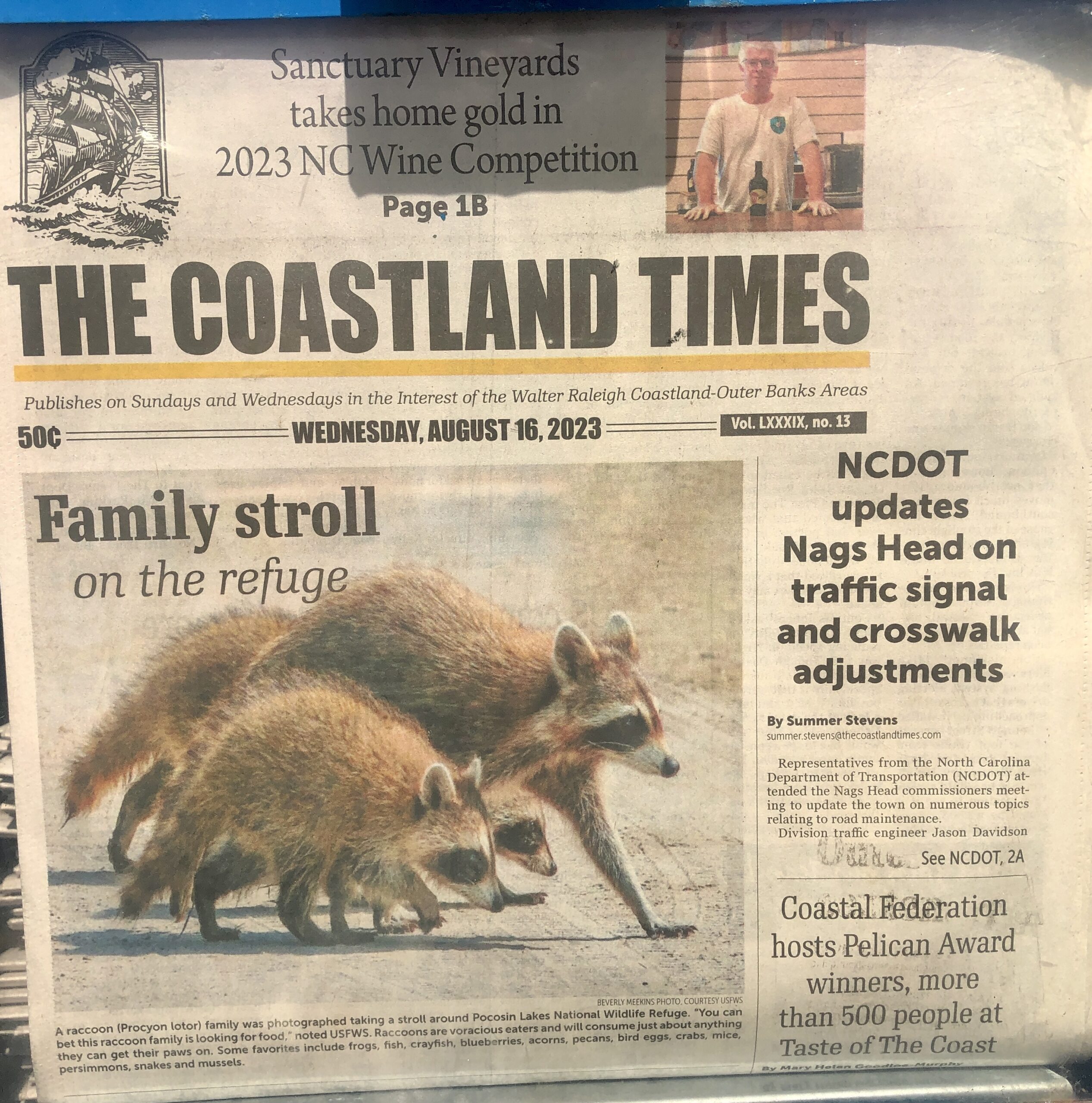4. 17 agosto 2023 – Outer Banks
Qui non è Nuova York – Verso sud con Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi
C’è un pezzo di Italia sull’isola di Roanoke, nella striscia di terra delle Outer Banks, lungo la costa della Carolina del Nord. È la statua Virginia Dare, scolpita in marmo di Carrara nello stile neoclassico, dall’artista americana Louisa Lander mentre viveva e lavorava a Roma, dal 1855 al 1860. Una delle “sorelle scultrici” americane trapiantate nella Città Eterna in quegli anni e raccontate da Maria Teresa nel libro “Emma e l’Angelo di Central Park”.
Andiamo a trovarla negli Elizabethan Gardens, poco lontano dal motel dove alloggiamo. I giardini sono di fianco al sito storico nazionale di Fort Raleigh, dove il ranger che ci racconta la storia della Lost Colony non sembra entusiasta di parlarci anche di Virginia Dare.
La statua infatti è, nell’immaginazione di Lander, la rappresentazione da adulta della bambina nata nel 1587 nella prima colonia degli inglesi in America, proprio qui sull’isola Roanoke. Una colonia di 107 fra uomini, donne e bambini sparita nel nulla: quando nel 1590 il capitano che li aveva portati qui ritorna, non ne trova alcuna traccia. E da allora studiosi e archeologi si arrovellano sul perché: sono morti di fame e malattie come capitava a molti coloni? Uccisi dai nativi americani con cui non avevano buoni rapporti? Sono andati via in cerca di una terra più ospitale?
Nessuna risposta finora è stata scientificamente provata.
La leggenda vuole invece che Virginia sia sopravvissuta e si sia integrata fra i nativi americani, gli Algonquian. Ed è così che se l’immagina Lander, come una principessa indiana.
Il bianco del marmo di Carrara quasi ci abbaglia, sotto il sole cocente. La principessa è nuda, tranne che per una rete da pesca avvolta attorno ai fianchi. Bellissima, alta, sensuale, lo sguardo sereno verso l’oceano. E scandalosa per la morale puritana. Per questo la statua è stata a lungo boicottata, nascosta e dimenticata, ed è arrivata qui solo negli Anni Sessanta del Novecento, quasi un secolo dopo la sua creazione.
Scandalosa era stata anche l’artista Lander, andata a Roma non solo per imparare l’arte della scultura dai maestri del neoclassicismo, ma anche per vivere liberamente, lontano da benpensanti e bigotti. Quando viene accusata di avere un affaire ed esclusa dai salotti buoni degli americani expat, sono le sue “sorelle” come Emma Stebbins – l’autrice dell’Angelo delle Acque a Central Park, anche quello “nato” a Roma – a difenderla.
Mentre ammiriamo Virginia Dare, sotto le fronde di una maestosa antica quercia del sud, ci piace pensare al filo rosso che lega la principessa indiana all’Italia e anche a New York.
La giornata era cominciata al Parco Nazionale eretto per celebrare i Fratelli Wright in Carolina del Nord. La guida volontaria Chip Walton trova la frase esatta per spiegare l’importanza della loro invenzione: “Pensateci. Il 17 dicembre 1903 Wilbur e Orville hanno insegnato al mondo a volare e il 21 luglio del 1969 Neil Armstrong è sbarcato sulla Luna. Tra le due imprese sono passati meno di 66 anni. Questo dice quanto sia stata fondamentale la loro scoperta nel liberare la potenzialità creativa dell’uomo”.
Da Icaro, passando per Leonardo da Vinci, l’umanità ha sempre guardato al cielo come a un mondo da conquistare ma non ha mai saputo farlo, tenuta a terra dalla legge della gravità. Ci volevano due scienziati autodidatti in ingegneria senza aver finito il liceo, dalla personalità schiva e dalla determinazione d’acciaio, nati in Ohio nell’Ottocento, per aprirci la strada alla navigazione celeste.
Quel giorno il freddo era terribile nella Carolina del Nord, ma i due fratelli, dopo quattro anni di studi e di esperimenti di volo con gli alianti da una collinetta, avevano deciso. Era era arrivato il tempo per librarsi in aria, partendo dal suolo piatto e sospinti da un motore propellente, fatto da loro stessi, ben consci che sarebbero atterrati… dove? Sicuramente alla stessa altitudine dell’avvio, ma planando da quale altezza? E quanto tempo dopo?
A visitare il Wright Brothers National Memorial si hanno tutte le risposte, ma non solo. Ci si immedesima nella loro impresa, e nelle loro paure. Prima di decollare, si sa che i due si strinsero la mano, salutandosi come fosse per l’ultima volta. Portarono ad assistere al tentativo un ragazzino di 16 anni, per avere un testimone. Lui, che non aveva mai scattato una foto in vita sua, fece quella che è diventata un’icona. A terra si vede Wilbur che guida l’operazione, e in aria c’è il velivolo guidato da Orville.
Non era la prima volta che un veicolo si era alzato da terra, ma in precedenza erano aerei che erano stati spinti su da un motore “bruto”, non governato. Che poteva teoricamente anche mantenere il velivolo sollevato per qualche tempo, ma senza che ci fosse alcun controllo dell’operazione da parte del pilota.
Il genio dei Wright è stato di capire che l’uomo volante doveva gestire, controllare il volo nell’aria: da sé, come fanno gli uccelli. I problemi non potevano insomma essere risolti da terra. Questa era la loro filosofia, espressa dalle parole di Wilbur: “È possibile volare senza motori, ma non senza la conoscenza e la capacità”. Intendeva, Wilbur, senza la padronanza e lo studio delle leggi della fisica che gli uccelli praticano naturalmente. Per arrivare al traguardo dei primi voli del 17 dicembre i fratelli si erano allenati migliaia di volte su un aliante che facevano partire da Kill Devil Hill. Questa collinetta, nel parco nazionale dei Wright Brothers vicino all’Oceano Atlantico, ospita oggi l’enorme monumento dedicato all’impresa. La montagnola ha una caratteristica unica: essendo stata all’origine una duna di sabbia, che come tutte le dune delle Outer Banks si spostano naturalmente con il vento, non avrebbe mai potuto sostenere tale peso. È stata quindi rafforzata con terra e pietre per questo scopo, e non slitta più. La gente ci va in pellegrinaggio a migliaia (anche oggi che pioveva, con più bambini che adulti) per il tributo di rito a due veri eroi della scienza applicata. Il movimento aereo era nel loro destino, ma quando dall’Inghilterra arrivarono le prime biciclette, aprirono un negozio che è stato il business della loro vita. Non solo come affare commerciale. Aggiustando le bici, e studiando la loro velocità e i meccanismi, si immersero nel contesto tecnico-psicologico che si sposava con la loro vera ossessione. Che era quella di volare.
Non avevano tanti soldi e non ebbero mai una moglie. Con la loro passione di “risolvere i problemi” possono essere iscritti idealmente nel filone di pensiero che in tutto il mondo, a partire dai futuristi italiani, vedeva nella tecnologia, e nella scienza che bruciava le tappe per svilupparla, un obiettivo irresistibile di vita. Gli strumenti sui quali i due fratelli lavorarono erano naturalissimi, peraltro: il vento, la sabbia, e… l’isolamento dagli altri, per non essere disturbati. I tre problemi cardinali, o meglio le tre componenti della fisica che affrontarono con disciplina maniacale, emergendone vincitori, erano il controllo del velivolo, l’ampiezza delle ali in rapporto con la leggerezza, e la propulsione.
Il successo, anche per gli scienziati autodidatti, si misura con i numeri. In quello storico e gelido 17 dicembre, con il vento a 43 km all’ora, il traguardo significa una sequenza di quattro voli riusciti. Tutti all’altezza di circa tre metri dal suolo, in una successione costante di miglioramenti. Il primo volo, di Orville, durò 12 secondi, a una velocità di 10,9 km orari, e finì 37 metri dopo. Il secondo, di Wilbur, durò ugualmente 12 secondi ma arrivò a 53 metri. Poi toccò ancora a Orville, che percorse 61 metri in 15 secondi. La quarta performance finale fu sempre dello stesso Orville, che rimase in aria per 59 secondi e atterrò 260 metri dopo.
Il resto è storia. E la lezione, che la guida ha tratto in perfetto spirito americano è: “Tutte le loro qualità tecniche sono innegabili, ma una è quella determinante. Avere un sogno, e crederci fino in fondo”. In questo caso, fino in cielo.
Cliccate su ogni foto per leggere la didascalia